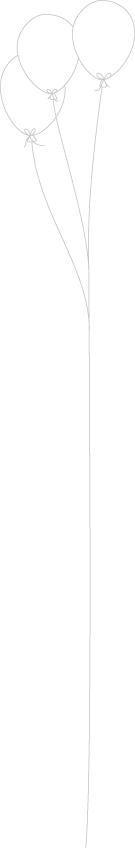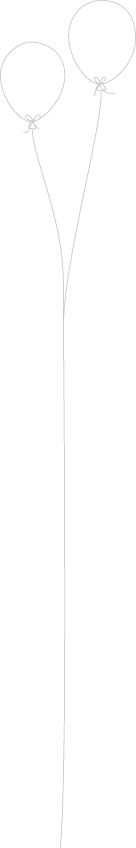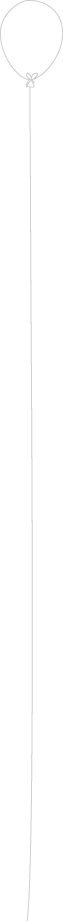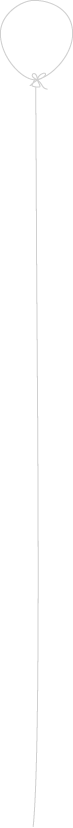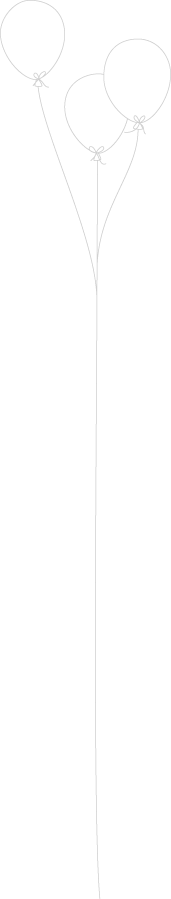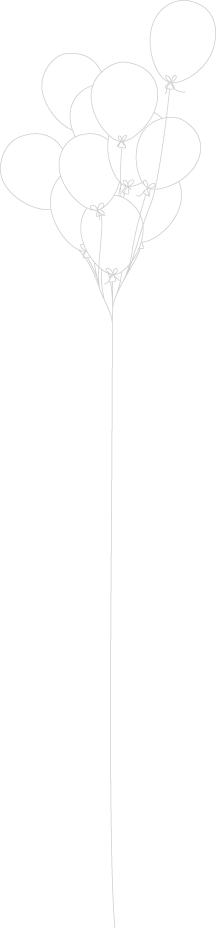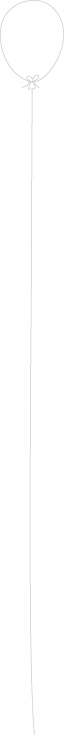Non sono più un ragazzino di primo pelo, ma al primo collegio di quest’anno, per la prima volta dopo tanti anni, troppi mesi di non scuola, qualche giorno d’angoscia, ero quasi felice di cominciare un nuovo anno.
Dopo un’estate rigenerante, non mi mancava certamente la Dad, quelle lunghe cerimonie per apparire pronto e passabile al filtro delle telecamere, il rischio di mandare in onda i suoni della famiglia, la goffaggine nell’aprire il collegamento, e così vedere era bello, anche se toccare vietato e il futuro guastava la gioia.
Appena si girava l’angolo, infatti, si era risvegliati dalla batteria di dispenser all’ingresso delle aule e impossibile era pensare che tutto potesse continuare come nei primi, ottimistici giorni.
L’unica cosa certa di quest’inizio di anno scolastico era che i ragazzi non avrebbero più potuto fare i ragazzi.
Non si sarebbero più incrociati con gli amici degli altri corsi all’ingresso, non si sarebbero dati più pappine all’uscita, non avrebbero potuto più dirsi nelle orecchie i segreti tenuti compressi per ore. Nessuno avrebbe aspettato più il compagno reo d’averlo provocato in classe per fargliela pagare, e in autobus al massimo avrebbe potuto regalargli uno sguardo triste e impotente.
La merenda avrebbe dovuto portarsela da casa, e la mascherina pure, e non avrebbe potuto togliersela se non per chiedere al professore di alzare la voce, che con questi bavagli si perde pure il suono delle parole.
L’unica cosa certa di quest’inizio di anno scolastico era che i ragazzi, in queste tre, o cinque ore, di quarantacinque o di cinquanta minuti, avrebbero dovuto rispettare le regole soltanto per paura, pura, incomprensibile, banale paura.
Nonostante ciò questo rientro in presenza era già un successo, e dagli stessi ragazzi, pur imbavagliati e immobili, è stato vissuto come tale. Così, sentirsi dire: “Prof, ci manda sulla piattaforma un compito da fare”, è stata una sorta di rivoluzione copernicana, senza eguali. Come se paradossalmente il punto più basso dell’esperienza scolastica degli ultimi anni abbia generato naturalmente una consapevolezza nuova. Che la scuola sia per tutti il valore più importante, nonostante la classe perfetta sia ora rappresentata da un gruppo di dodici alunni distanziati e immobili, e con le mascherine tirate su come il regolamento prevede. D’altronde il lockdown ha fatto i suoi danni, e anche se non lo vogliono ammettere loro sono contenti d’essere a scuola. Certo, le regole impongono un’osservanza ferrea, a cui non sono abituati, ma dopo un po’ è solo una questione di ritmo.
Mascherina, distanziamento, dispenser… mascherina, distanziamento, dispenser.
C’è chi si chiede che senso abbia tutto questo, se poi, oltre il cancello, si ammassino tutti sui pullman stipati, ma la scuola deve dare l’esempio, e in fondo questo è il ruolo che le compete.
Ogni storia, anche la più brutta, ha la sua percezione più profonda.
Questa è ancora inafferrabile, ma non è lontana dall’essere compresa. L’emergenza si pratica sul campo, non in teoria. Chi critica la coraggiosa ostinazione dell’istituzione scolastica a volerci provare, non ne ha capito la funzione più profonda, che è quella di favorire le dinamiche sociali più complesse per curarle, e guidarle al risultato migliore.
Si vocifera di classi, di scuole chiuse, ma la sfida più grande dev’essere quella di abbattere le paure con la volontà di resistere, aggrapparsi a un’aula, una Lim, un tablet che potrebbe salvarci la vita.
“Prof, ma quest’anno ci saranno i laboratori, i Progetti, l’alternanza?”, queste sono le domande più belle, e già poter rispondere di sì rappresenta una vittoria senza eguali.